A cavallo tra scienza, filosofia, esoterismo
Venerdì 10 dicembre, ore 17:00, presso l’Istituto di Studi Filosofici di Napoli, Palazzo Serra di Cassano, via Monte di Dio n.14, si terrà la presentazione del libro di Salvatore L. d’Ascia ‘Scienza, scientismo, transumanesimo – Studio monografico a carattere esoterico’, edizioni Tipheret, collana Punto Luce, che reca una densa prefazione di Claudio Bonvecchio.
Moderatore Giuseppe Troise. Interventi Claudio Bonvecchio, Salvatore L. d’Ascia e Michele Fasolino. Letture di Patrizio Rispo.
Argomento scomodo, ma terribilmente attuale, analizzato da più angoli di osservazione quello su cui si incentra il testo di d’Ascia, esperto in comunicazione, sceneggiatura, fumetto, esoterismo, considerato opinion leader in cardiologia, presente in diverse antologie, autore dei romanzi ‘Supersonico’, Rai Eri, 2016, ‘Black Magic’, Woijtek, 2019, e del saggio ‘Magia e Massoneria, comprendere il mondo iniziatico‘, Edizioni Mediterranee, 2019.
Attraverso un’approfondita analisi, condotta anche grazie all’ausilio di una consistente bibliografia di autori italiani e stranieri, contemporanei e non, articoli a stampa, sitografia, siti web, motori per l’esegesi biblica in lingua italiana ed ebraica, d’Ascia, partendo da note di edizione, dopo una debita premessa sul significato del laico e del sacro, si sofferma, appunto, sui concetti di scienza, scientismo e transumanesimo per poi riepilogare, mediante tabelle schematiche, lo stato dell’arte.
L’Umanità, quasi definitivamente spodestata del senso del sacro e dell’inviolabilità del singolo, restituisce l’immagine dell’individuo ridotto ormai ad asettico automa.
La riflessione è rivolta verso quella scienza che, arrogandosi il diritto di sostituirsi al divino, si spinge oltre ogni concepibile limite bio-etico e si congiunge in uno scientismo totalitario autoesaltante, in un transumanesimo deviato che si realizza in sperimentazioni eccessive, utilizzando, ad esempio, meccanica, robotica ed intelligenza artificiale per mutazioni genetiche e mercimonio della tecnologia o, ancora, crudele accanimento terapeutico.
Lettura non facile, ma doverosa per risvegliare le coscienze di fronte ad un domani nemmeno troppo lontano che ci attende, se non addirittura già presente.
Tanti gli spunti offerti da un testo così particolare, che contattiamo Salvatore, affinché soddisfi alcune curiosità.
Il tuo ultimo lavoro reca la prefazione del Prof. Claudio Bonvecchio, accademico noto, tra l’altro, per i suoi molteplici scritti sulla tradizione esoterica, che definisci, nella dedica, il tuo ‘autentico maestro’ e a cui fai riferimento, nella bibliografia, per ben quattro testi. Quanto e come la sua figura di intellettuale ha contributo alla tua formazione filosofico – esoterica, considerato che, in una recente intervista che ci ha rilasciato, ha rimarcato la necessità di ricostituire un nuovo Umanesimo?
Senza il pensiero di Bonvecchio non ci sarebbe il mio e lo dichiaro apertamente. Al pari delle mie guide in medicina, è stato per me un riferimento da molto prima che ci conoscessimo.
Studio attentamente ogni suo testo, ogni sua affermazione, e ritengo sia uno dei pochissimi pensatori moderni capace di unire l’azione alla speculazione.
Bonvecchio, insomma, è un filosofo all’antica, come i greci: uno scienziato della filosofia. Un sapiente esemplare, che però si cala quotidianamente nel mondo per poterlo trasformare.
Uno studio monografico su tematiche importanti che ti vedono impegnato nella doppia veste di cardiologo ed esoterista. Come si arriva a conciliare aspetti apparentemente così opposti e, soprattutto, al di là del pubblico di nicchia a cui ti rivolgi, non senti l’esigenza di doverti dedicare ad una platea più vasta, così che il tuo messaggio sia ancor più incisivo?
Non penso di rivolgermi ad un pubblico di nicchia, ma di certo non scrivo opere mainstream.
In effetti, purtroppo, la nicchia sono proprio i lettori, tutti i lettori, perché oggi leggono sempre meno persone anche se, paradossalmente, sono tutti opinionisti.
Io penso non si debba avere sfiducia nel lettore moderno e, anzi, si debba vivere con lui la profonda e costante trasformazione della comunicazione.
Ci si deve provare, insomma, e non si deve sottovalutare questa chimera che è il lettore. Non si deve pensare che sia superficiale, o impreparato – troppo piccolo, o grande – e, dunque, si deve rispettare con lui una sorta di patto. Idealizzare uno spazio in cui il fruitore, di qualsiasi forma e caratura, possa giudicarti e riflettere con te, contemplando il tuo scritto.
Un’opera a due, insomma, qualcosa che coinvolge un ideale sconosciuto, ma, al tempo stesso, gli apre porte: lasciando un filo rosso di continuità.
La cifra adeguata è per me a metà strada: in parte scrittura empatica e in parte scrittura razionale e, dunque, nei saggi, tento di essere divulgativo, ad esempio mediante forme brevi e auto-domande.
Per i romanzi, del resto, provo a essere non troppo semplice, sfidando me stesso e il mio lettore in una scrittura sempre densa di interpretazioni.
L’emergenza pandemica da Covid-19, come si evince dal saggio, ha ulteriormente posto in luce i limiti di autoreferenzialità della scienza, che, in molti casi, tendono a sfociare in una sorta di condizione auto-negante, riducendo il Mondo Divino e il Mondo Spirituale ed Archetipico al Mondo Fisico e Materiale, del tutto in contrasto con quell’articolazione del sacro che porta, invece, alla spoliazione dei metalli e al sostegno spirituale di cui l’Umanità ha impellente necessità. Quanto questa “Luce” salvifica è presente come strumento interiore nel tuo percorso verso la conoscenza?
Nel saggio non si accenna alla pandemia, anche proprio perché è argomento abusato, ma del resto come non pensarci visto il momento?
Ci riflette, ad esempio, il prefatore e giustamente la utilizza per evidenziare un fenomeno di scienza saccente, scienza confusa, ma questo non è nuovo, anzi.
È molto comune che la scienza si trovi sparuta, in contraddizione con se stessa, ma questa è proprio una molla indispensabile al progresso.
Ciò che è sbagliato, invece, a mio avviso profondamente sbagliato, è la massificazione di tale processo: la sua esposizione. La sua condivisione mediatica, la sua ridicolizzazione. Rendere i profani partecipi di meccanismi talmente delicati da coinvolgere solo pochi scienziati? E perché portare la massa in luoghi tetri e disperati: luoghi di scienza e sofferenza, come gli ospedali? O i laboratori?
Hanno loro gli strumenti, addestrati negli anni, per essere obiettivi, per non essere feriti? O, viceversa, li si sta solo massacrando con una sovra-esposizione?
Vedete, un medico ha degli strumenti particolarmente affilati e tuttavia se io sono cardiologo e mi rompo una gamba mi affido al collega: e basta. Non faccio indagini particolari, non metto in pubblica piazza il mio problema: semplicemente lo risolvo con la collaborazione. Giusti tempi e giusti luoghi. Un po’ di semplicità spesso ripaga: la luce, come giustamente tu affermi, è un centro interiore di calma e di sostegno.
Il Transumanesimo contro cui ti scagli è quello che partendo dalla scienza e confluendo in un perverso scientismo va ad esacerbare il ricorso alla tecnologia, inquinando la vita alle radici, restituendo, di fatto, l’individuo simile ad una macchina, negando ogni forma di Umanesimo, sottomettendo il reale al virtuale, in un processo destinato, alla lunga, a culminare in un futuro apocalittico, esasperato ed esasperante. In base alla tua esperienza medica, a che punto siamo? La distopia è ormai inarrestabile o c’è speranza di un’inversione di rotta?
Ci tengo a precisare di aver criticato il trans-umanesimo come movimento storico e scientifico e non come concetto. Anche il trans-umanesimo, insomma, è un pensiero alla deriva. Se così non fosse, preso come ‘puro’, esso sarebbe divertente, certamente stimolante.
Accattivante, per uno scienziato come me, e indiscutibilmente denso in potenzialità, ma purtroppo, negli anni, esso è stato comprato dal capitalismo occidentale che lo ha fatto deviare.
Una corrente di pensiero, insomma, va sempre rispettata, ma va anche contestualizzata senza ‘perdere il centro’, che poi sarebbe l’uomo da cui nasce quel pensiero.
La telecamera va puntata, quindi, sull’uomo, sempre sull’uomo, e non sulla tecnologia che egli produce. O sui vantaggi, comunque opinabili, che tale rapporto può portare. Scienza e non scientismo, insomma: idee e non ideologismo.
Circa un’inversione di rotta ritengo siamo troppo avanti e, del resto, non è possibile ribaltare dei processi oramai selezionati da migliaia di individui.
È giusto, però, affiancare le persone con sapienti preparati, reclutarli e attuare l’aggiustamento di rotta. Una rettificazione che riporti il trans-umanesimo nella canonica scienza: con funzione di pungolo e mai di deriva.
Le due suggestive immagini dell’uroboro e tomoye e dell’uroboro integrato al segno rischio biologico che proponi quasi alla fine del saggio, con le relative didascalie che indugiano sul significato del metallo e della meccanicità, in un ideale passaggio del testimone attraverso i secoli, sono l’ennesima rappresentazione dell’eterno movimento, della Tradizione perenne e primordiale, del Tempo divoratore, che, dal punto di vista alchemico, indicano la via della risalita dalla molteplicità all’Identità Suprema. Perché hai scelto di posizionarle proprio in quel punto? Cos’altro sottendono?
Questa intervista è piena di domande complesse, complimenti.
In effetti, questa è una domanda straordinaria e quindi risponderò progressivamente e contando almeno due livelli.
Livello primo: la tecnica di narrazione, in cui un’immagine ripaga più di mille frasi, e, quindi, alla fine del testo dona il tempo per la riflessione. Lascia un segno in quel ‘patto con il lettore’ a cui prima accennavamo.
Livello secondo, più complesso: le immagini inducono trasformazione. E quale dovrebbe essere il primato di un testo se non di trasformare chi lo scrive e chi lo legge?
Subito dopo, e sempre a fine testo, con una foto ricordi che il biologo Sir Julian Huxley fu il primo ad aver impiegato ‘scientificamente’ il termine trans-umano nel testo ‘New bottle for new wine’ del 1957. Cosa spieghi circa questo utilizzo e in che modo l’uso di un termine ha costituito un punto di rottura con l’immaginario precedente?
In effetti Huxley utilizzò il termine trans-umano nel testo citato – e lo pose anche impunemente sotto copyright – e tuttavia egli lo mutuò da scrittori precedenti.
Gabriele D’Annunzio lo aveva utilizzato nel testo ‘Fra’ lucertola’ riferendosi, però, ad un contesto totalmente differente, ovvero legandolo ai concetti di estasi, stupore e trasfigurazione.
Ora, è possibile che un ‘abbastanza grande’ come Huxley non conoscesse un gigante come D’Annunzio e, tuttavia, indifferentemente dai due, questo è un chiaro esempio di de-mitizzazione, ovvero un’espressione di secolarizzazione, nell’estensione semantica del termine. Si prende, insomma, un concetto primitivo, umanista, e lo si trasla in materia differente: cosa anche lecita se fosse sommazione e non mutilazione.
Il termine, prima rapportato al divino e pertinenza di un poeta, diventa infatti espressione di uno scientifico antropocentrismo e caratterizza solo un’azione dell’uomo verso l’uomo: a nostro avviso una perdita importante.
Prima della ricca bibliografia, dedichi uno spazio significativo a tabelle riepilogative dei principali argomenti sul dibattito bio-etico attualmente in essere, l’ultima delle quali si sofferma sui maggiori rischi del transumanesimo, evidenziando come affondino le radici in un background filosofico che contempla grandi studiosi: teoreti, matematici, scienziati, economisti. Saranno forse spunto di una successiva analisi da parte tua o sono dei sassolini di Pollicino affinché il lettore, girovagando nella boscaglia indistinta del lato oscuro dell’inconscio e favorendo il processo etico – valoriale, prenda consapevolezza della situazione?
Spero siano entrambe le cose e, anzi, vi aggiungo una terza possibilità: che siano uno strumento per tecnici e studiosi. Siamo in un’era multimediale, tridimensionale, e questo si applica alla comunicazione in generale, ma anche alla scrittura in particolare.
Ritengo giusto, o per lo meno accattivante, stimolare me stesso e chi mi legge con tutti gli strumenti possibili e quindi testo, immagini, tabelle. Motori di ricerca, bibliografia e sitografia e, persino, incontri de visu.
Collegandoci a un concetto più volte stressato, appunto un pensiero che si traduce in azione e che prova, incessantemente, a penetrare il quotidiano.
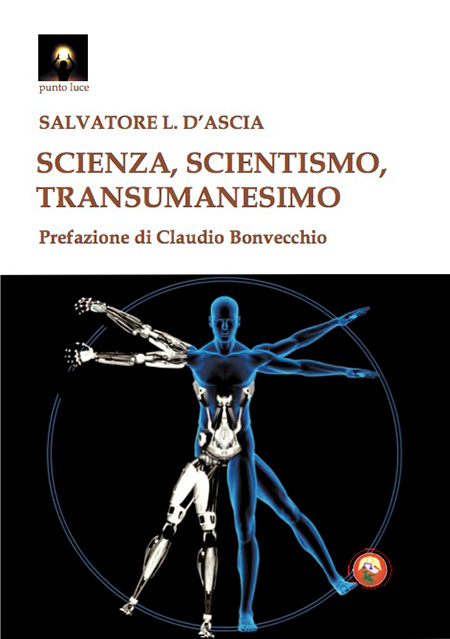
Autore Lorenza Iuliano
Lorenza Iuliano, vicedirettore ExPartibus, giornalista pubblicista, linguista, politologa, web master, esperta di comunicazione e SEO.





























































































